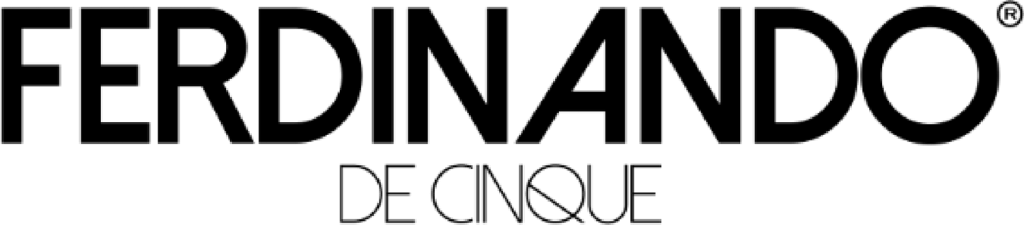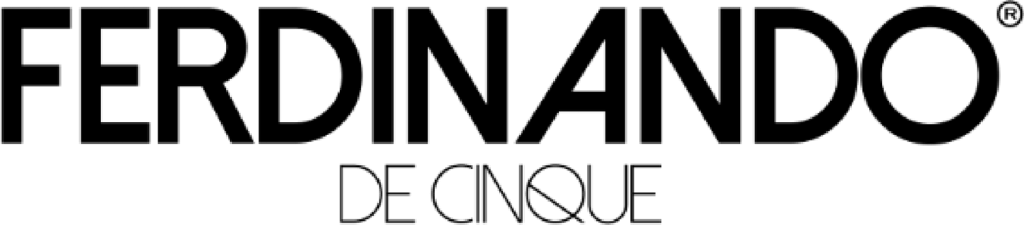
Ferdinando De Cinque, avvocato, deputato e letterato, nacque a Casoli nel 1876 da una rilevante famiglia di notai della zona.
Studiò giurisprudenza all’università di Bologna e di Genova, laureandosi nel 1901 con una tesi dal titolo “Della mezzadria”.
L’ateneo bolognese era all’epoca un vero e proprio focolaio di patriottismo, dove gli studenti comiziavano, spesso osservati dai docenti e dallo stesso Rettore; Ferdinando era fra questi oratori che, come in una gara di eloquenza, si sfidavano in udienze simulate o in conferenze tematiche, stimolando le sue doti di conferenziere e le sue ambizioni, fino a divenire uno degli avvocati più famosi del foro bolognese.
Dante Manetti lo descrisse così: “ingegno agile, profondo, osservatore acuto, si trovò dapprima a disagio nell’ambiente forense. S’era fitto in capo di impostare la causa, attraverso divagazioni, apparenti divagazioni, delle visioni di vita letteraria, politica e filosofica. Tutto ciò veniva giudicato un’originalità di difficile riuscita. Quindi critiche benevoli o sarcastiche, e l’appellativo di… poeta. Ma De Cinque, forzando il fatto, gli dava forma di dramma, giungendo alla commozione degli ascoltatori. Sicché alla prima ostilità subentrò l’interesse: egli riusciva, attraverso il sentimento, a vincere quello che non si poteva col ragionamento giuridico.”
Partecipò attivamente in diversi conflitti, combattendo nel 1897 nella legione delle camicie rosse a Domokos a fianco dei greci contro l’Impero ottomano e come volontario nella I guerra mondiale.
A Bologna, Ferdinando fece anche parte di diverse associazioni patriottiche, in particolare della “Trento e Trieste”, di cui fu uno dei principali oratori; il suo impegno politico e culturale per il movimento irredentista trovò completa conclusione con l’entrata del Regno d’Italia nel Primo conflitto mondiale.
A Bologna, infatti, avevano trovato rifugio molti rappresentanti dell’irredentismo triestino, complice l’attrattività dell’Università e il clima di accoglienza per questi esuli.
Schierati sul Podgora, il gruppo di volontari di cui faceva parte Ferdinando venne incaricato di recarsi nella notte ad aprire varchi fra i reticolati austriaci, per poi procedere al mattino successivo all’assalto delle posizioni imperiali; l’attacco che ne seguì fu una vera e propria ecatombe: tra i feriti vi fu anche Ferdinando stesso, colpito sia dalle schegge di una bomba a mano, sia da alcuni colpi.
Insignito della medaglia d’argento al valore militare, venne assegnato all’ufficio stampa e propaganda del corpo d’armata di Bologna con il grado di capitano e collaborò con il Resto del Carlino.
Attivo anche nel panorama politico, nel 1900 già erano note le sue idee politiche repubblicane mazziniane, non certamente un viatico semplice in una città prettamente socialista come Bologna; ma Ferdinando era rispettato e fungeva da uomo di dialogo fra le due fazioni.
Forse anche per questo motivo iniziò a frequentare molto anche la Romagna, aprendo uno studio legale a Faenza.
Nel 1908 venne eletto nel Consiglio del Comitato Centrale del Partito Repubblicano Italiano per l’Emilia-Romagna.
Prese inoltre parte al collegio di difesa di Pietro Nenni, all’epoca segretario della Camera del lavoro di Forlì, arrestato per lo sciopero contro la guerra di Libia del 1911, riuscendo a ridurre la pena comminata.
Nel 1909, forse anche per la sua crescente notorietà, la Pubblica Sicurezza aprì un fascicolo a suo nome presso il Casellario Politico Centrale.
Come legale, specialista in penale, avrebbe potuto trarre ben più cospicui guadagni, mentre in realtà spesso accettava cause pro bono: “io non valuto il soldo” soleva dire.
Nel primo dopoguerra, Ferdinando aderì fin da subito al movimento fascista, riconoscendosi in quella minoranza che reclamava riconoscimenti per gli ex combattenti e che rivendicava un ruolo di primo piano per l’Italia e si legò alla figura di Leandro Arpinati.
Ricoprì la carica di deputato dal 1929 al 1934, ma, nonostante questo, non cessò la sorveglianza nei suoi confronti e presso la Polizia Politica Fascista fu aperto un nuovo fascicolo a suo nome per intercettare e leggere la sua corrispondenza.
Ben presto, però, perse sempre più fiducia nel regime che aveva inizialmente appoggiato, in particolare dopo la fine politica di Arpinati e dopo la promulgazione delle leggi razziali.
Con lo scoppio della Seconda guerra mondiale, e soprattutto con la presenza delle truppe tedesche in Italia, mantenne un ruolo marginale nella politica fascista bolognese, tanto che durante l’occupazione tedesca fu sospettato di attività antifasciste e subì diverse perquisizioni.
All’entrata delle truppe alleate a Bologna, sia lui che la moglie Matilde accolsero i liberatori in centro a Bologna: lei adornata con un peplo tricolore, lui in camicia rossa, a fianco dell’amico Bauer, compagno garibaldino di religione ebraica, ospitato con la famiglia in uno scantinato di proprietà di Ferdinando, il quale non mancò di rifornirli di vivere e beni di sostentamento anche durante il periodo più buio dell’occupazione tedesca.
Gli ultimi anni della vita di Ferdinando si svolsero tranquilli nella sua Bologna, circondato dai suoi libri, dai suoi scritti e dalla sua collezione di oggetti d’arte.
Si spense nel 1950 e fu sepolto nella tomba di famiglia del suo paese natale.
Uomo poliedrico e dalla costante passione per lo studio, la sua vita è stata costellata di esperimenti e una profonda curiosità per il mondo che lo circondava.
Nei primi anni del ‘900 iniziò a mettere in pratica le sue conoscenze sulle botaniche, giocando con nuove combinazioni e sapori, spinto dalla stessa curiosità intellettuale che lo aveva reso un oratore così efficace e un avvocato così appassionato.
Ferdinando non rivelò mai le formule dei suoi liquori, che resteranno custodite nei suoi appunti, tra i quali si possono annoverare almeno un centinaio di procedimenti per le creazioni più disparate, con varianti e correzioni.
Questi documenti, veri e propri tesori di conoscenza, rappresentano oggi uno dei cuori pulsanti di Bad Spirits: ogni bottiglia della linea Ferdinando porta con sé un pezzo di questa straordinaria eredità, unendo la passione per l’eccellenza alla maestria artigianale contemporanea.
Da citare tra i suoi molteplici interessi anche quello per la scrittura che culminò con la pubblicazione di una raccolta di poesie e racconti nel 1944, intitolata “Scheletri, cani, lupi e ninfee”; attualmente, le copie disponibili in circolazione sono rarissime.
Così, a più di settant’anni dalla sua scomparsa, Ferdinando De Cinque continua a vivere attraverso i sapori unici dei nostri liquori, testimonianza di una vita vissuta con passione, coraggio e una costante ricerca della perfezione.